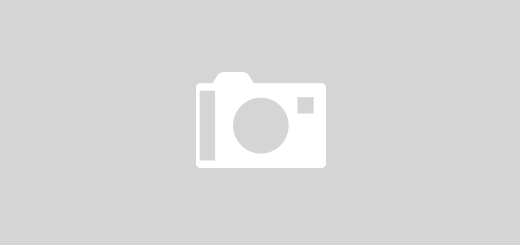La tutela dei beni pubblici e dei beni comuni
I ccdd. beni pubblici sono ricompresi nella categoria giuridica della proprietà pubblica menzionata dall’art. 42 Cost.. Sono tali i beni dei quali si avvalgono le PA per realizzare i propri fini istituzionali e, pertanto, sono sottoposti a un regime particolare.
Questo trova fondamento nella Costituzione all’art. 42 citato, e sul piano sovranazionale nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale stabilisce che i Trattati “lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”, dimostrando al riguardo un atteggiamento neutrale. Infine, il codice civile, in ambito nazionale, dedica il Capo II del Titolo I del Libro III ai beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici.
In particolare, il genus dei beni pubblici è tradizionalmente suddiviso in due sottocategorie, rappresentate dai beni pubblici in senso stretto, che appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico, e dai beni di interesse pubblico, che appartengono a privati ma sottoposti a uno speciale regime derogatorio in virtù della peculiare rilevanza attribuita agli stessi dalla collettività dei consociati che, di solito, ne fruisce.
Infatti, la proprietà privata anche se riconosciuta e garantita dalla legge, può essere conformata dal potere pubblico allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla appetibile a tutti.
Anche la Carta di Nizza all’art. 17 tutela il diritto di proprietà e al contempo prevede che l’uso dei beni possa essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Coerentemente il codice civile reca varie disposizioni intese a conformare il diritto domenicale privato a fini di interesse pubblico.
Soffermandoci sulla prima delle due categorie sopra individuate, occorre dar conto del dibattito sorto in merito all’individuazione dei criteri che consentono di qualificare un bene come pubblico.
Una prima ricostruzione attribuisce valore pregnante alla natura giuridica del soggetto proprietario; dunque, sarebbero pubblici tutti i beni che appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico.
Si è osservato in senso critico, però, che la PA può possedere beni, come quelli disponibili, che sottoposti a un regime giuridico di diritto privato, non si discostano dai beni di proprietà dei privati.
Altro orientamento privilegia la particolarità della disciplina applicabile. Sarebbero, pertanto, pubblici, tutti i beni accomunati dai caratteri della inalienabilità, della non sottoponibilità a usucapione, della presenza di un vincolo di destinazione e da tutti i connotati specifici propri della categoria.
Alle precedenti opzioni se ne contrappone una terza, che fa leva sull’assolvimento di finalità pubbliche. Anche questa tesi pecca per eccesso in quanto include anche i beni di interesse pubblico che però appartengono a una separata categoria, ossia ai privati.
Secondo la dottrina gli elementi costitutivi della classe pubblica sono essenzialmente due: uno strutturale e l’altro funzionale, l’essere di proprietà di un ente pubblico e l’ essere finalizzato alla soddisfazione di un pubblico interesse.
Alla superiore lettura aderiscono le SSUU nel definire il regime delle Valli da pesca della laguna di Venezia, le quali dunque, a prescindere da disposizioni e provvedimenti di natura amministrativa, costituiscono beni pubblici, anche in virtù della loro strumentalità alla realizzazione di valori costituzionali.
Infatti, secondo i giudici di legittimità non è più possibile limitarsi all’esame della sola normativa codicistica per delimitare le categorie dei beni pubblici o demaniali. Sarebbe impensabile, infatti, tralasciare le altre fonti dell’ordinamento come quella costituzionale. La nostra Carta Costituzionale, se pur non contenente, un’espressa definizione dei beni pubblici, né una loro classificazione, stabilisce alcuni importanti richiami per la definizione del sistema positivo.
In particolare, l’art.2 inferisce il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale e del paesaggio; fa specifico riferimento non solo ai beni che costituiscono il demanio o sono oggetto della proprietà dello Stato, ma anche a quelli che, per loro intrinseca natura o finalizzazione, perseguono il soddisfacimento degli interessi della collettività.
L’art. 9 Cost. prevede che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, con un’affermazione che si colloca tra i principi fondamentali e che ha costituito il fondamento per una ricca legislazione in tema di beni culturali.
L’art. 42 Cost., inoltre, pur essendo incentrato prevalentemente sulla proprietà privata, esordisce come la dicotomia pubblica-privata, implicando il riconoscimento della diversità di fondo fra i due tipi di proprietà.
Se ne ricava, pertanto, il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell’ambito dello Stato sociale, anche in relazione al “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività; pertanto, da definire “comuni”per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale.
Ciò prescinde dal titolo di proprietà, ma si basa sulla compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività.
Il che comporta per l’ente titolare anche la sussistenza di oneri di “governance” finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.
Di recente, la riforma attuata con la legge costituzionale n.3/2001 modificando il Titolo V della parte seconda della Costituzione, ha ricompreso nella potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, e dei beni culturali; mentre ha previsto la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni per ciò che riguarda la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Da tale quadro normativo-costituzionale emerge e resta fermo il dato essenziale della centralità della persona e dei relativi interessi da rendere effettivi, anche mediante l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Si palesa l’esigenza interpretativa di affrontare il tema dei beni pubblici oltre la visione patrimoniale-proprietaria, per approdare a una prospettiva personale-collettivistica.
Da ciò deriva che più che allo Stato inteso quale apparato, o persona giuridica pubblica, si debba far riferimento alla dimensione collettiva di ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza, o quale ente preposto alla effettiva realizzazione degli stessi.
Perciò, disquisire in termini di sola dicotomia beni pubblici-privati, o di sola individuazione della titolarità, significa perdere l’ineludibile classificazione degli stessi in base alla relativa funzione e agli interessi a essa collegati.
Ne consegue, quindi, che un bene, a prescindere dalla sua titolarità, se risulta destinato alla realizzazione dello stato sociale per le sue intrinseche connotazioni, soprattutto di tipo ambientale e paesaggistico, è da ritenersi “comune” in quanto strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini. E ciò al di là della datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica.
Come anticipato, le SS.UU. hanno concluso che il solo aspetto della demanialità non appare esaustivo per individuare i beni che sono caratterizzati da un godimento collettivo o sono funzionali agli interessi della collettività. In tal modo, l’aspetto domenicale cede il passo alla realizzazione di questi interessi, in quanto fondamentali e indispensabili per un compiuto svolgimento dell’umana personalità.
Ed è proprio la superiore prospettiva a essere adottata per inquadrare le valli da pesca citate, con esclusione delle zone emerse, poiché dotate di una funzionalità e di una finalità pubblica-collettiva.
I beni comuni, dunque, secondo la definizione elaborata da Stefano Rodotà, si caratterizzano perché strumentali al godimento dei diritti fondamentali della persona. Per questa ragione, la loro gestione deve essere collettiva, superando la dicotomia tra pubblico e privato. Sono beni comuni, definiti in dottrina anche “benicomunisti”, quindi, aria, acqua, foreste e, in generale, tutte le risorse naturali, nonché quelle archeologiche, ambientali e culturali.
A livello internazionale, la teoria della gestione collettiva dei beni comuni è stata ampiamente elaborata da Elinor Ostrom, politologa statunitense e Premio Nobel per l’economia nel 2009. È stata lei la prima a contestare il modello della “Tragedia dei beni comuni”, che negava la possibilità di identificare una terza via tra libero mercato e statalismo. In Italia, uno dei momenti di massima mobilitazione sull’argomento è stata la campagna referendaria per l’acqua pubblica del 2011.
Oggi, il tema dei beni comuni si intreccia con le grandi questioni ambientali, con le lotte per i diritti sociali e con le nuove elaborazioni su democrazia e cittadinanza.
I beni comuni, dunque, sono necessari per la vita o preordinati a realizzare interessi di particolare rilevanza per gli individui, poiché investono diritti fondamentali delle persone o evocano loro radici culturali o ragioni identitarie; si caratterizzano per la non esclusione dall’uso generale, con conseguente non assoggettabilità ad un prezzo quale corrispettivo del loro utilizzo.
Ciò, soprattutto in tempi di crisi economica, li pone in controtendenza rispetto all’assoggettamento dei beni pubblici alle logiche del mercato, attraverso forme di privatizzazione o di gestione privata. Gli stessi beni sono, inoltre, correlati ad una comunità di riferimento del bene che intorno agli stessi si crea o, qualora già esistente, si rafforza.
Tuttavia, vi sono incertezze sulla definizione di bene comune, sulle tipologie di beni che entrerebbero a farne parte, sul concetto di comunità.
E’ stato invocato il riconoscimento legislativo della nuova categoria, nell’ambito dell’auspicata riforma della disciplina dei beni pubblici di cui al capo II del titolo I del libro III del codice civile. Noto è lo schema di disegno di legge delega elaborato nel 2012 dalla c.d. Commissione Rodotà, appunto.
Pur in mancanza di una disciplina generale, la legislazione, soprattutto regionale ma anche nazionale, ha fatto espresso riferimento ai beni comuni, ad esempio, in tema di governo del territorio, consumo del suolo e acque.
Le citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto taluni beni demaniali in tema di Valli da pesca venete, come funzionali ai diritti fondamentali di determinate collettività, definendoli espressamente beni comuni.
Anche il Consiglio di Stato ha affermato che lo sfruttamento privato del bene comune porta ad un impoverimento della comunità; il caso è quello di una concessione da parte di una Regione ad una ditta produttrice di acque minerali del diritto di sfruttare una fonte riferibile ad una comunità.
Molti Comuni, il cui numero è in costante espansione, hanno approvato dei regolamenti per la cura e la gestione dei beni comuni, attraverso forme di amministrazione condivisa con i cittadini. A fianco a tali buone pratiche si sono sviluppati casi di occupazioni illegittime di beni pubblici o privati, rivendicati come comuni, da parte di gruppi di cittadini; si pensi al caso del Teatro Valle a Roma, chiuso da anni tra le polemiche per lavori di restauro e dal 2018 riaperto temporaneamente come spazio espositivo collettivo, in attesa di poter ospitare nuovamente gli spettacoli dal vivo.
La dottrina non ha tardato a riconoscere la categoria dei beni comuni come una sorta di contenitore nel quale collocare anche gli usi civici previsti dalla l. 16.6.1927 n. 1766. Le tesi riferite a tali istituti possono costituire un punto di partenza per la costruzione di una teoria generale dei beni comuni.
Tutto ciò porta a ritenere che la categoria dei beni comuni già esista nel nostro ordinamento e pone problemi teorici afferenti la loro scarsità, si pensi all’acqua, e alla necessità conseguente di garantirne pari accesso e fruizione da parte dei consociati.
Tale emergenza, poi, è particolarmente avvertita con riguardo a taluni beni di nuova emersione quali la libertà di accesso a internet, come fonte di conoscenza, al cibo, all’acqua. Siffatti beni sono a titolarità diffusa e, pertanto, alcune ricostruzioni ne propongono una gestione informata ai principi di solidarietà ed eguaglianza, anche in una prospettiva intergenerazionale di lungo periodo.
Al fine dell’inserimento della teoria dei beni comuni tra quella dei beni pubblici e dei beni privati, si deve preferire, quindi, una classificazione fondata sul criterio oggettivo – funzionale della destinazione del bene, divenendo recessivo l’aspetto dell’appartenenza del bene. Si può, così, affiancare alle categorie pre-esistenti dei beni di interesse pubblico , o beni pubblici, e dei beni di interesse privato, o beni privati, quella dei beni di interesse comune, o beni comuni, preposti a realizzare l’interesse di una comunità, ovvero di ciascuno dei suoi membri, e non quello pubblico generale ovvero quello individuale.
La categoria dei beni comuni viene, dunque, ad individuarsi in relazione alla funzione di tali beni e in contrapposizione con la destinazione pubblica. Sotto tale profilo, se appare chiaramente pubblica la destinazione dei beni a soddisfare interessi peculiari della pubblica amministrazione, come nel caso degli uffici pubblici, più delicato appare distinguere tra destinazione pubblica e destinazione comune per i beni aperti all’uso generale.
Da un punto di vista definitorio, occorre fare riferimento all’uso comune per descrivere l’uso generale di un bene da parte di una determinata comunità o gruppo circoscritto di cittadini, in contrapposizione all’uso pubblico che spetta a tutti i cittadini indistintamente.
L’uso comune si differenzia da quello pubblico anche per intensità, poiché i beni comuni per i membri della comunità sono essenziali per la vita, afferiscono a diritti fondamentali delle persone, evocano loro radici culturali o ragioni identitarie. Tutto ciò non toglie che gli stessi beni possano anche arrecare utilità, di differente natura o intensità, a soggetti diversi dai membri della comunità: in primo luogo, alla collettività indistinta, essendo, dunque, anche beni a destinazione pubblica; in secondo luogo, a privati , ad esempio il soggetto al quale il bene appartiene, essendo anche beni a destinazione privata.
Emerge un rinnovato ruolo delle comunità, territoriali ma non solo, che si creano intorno a questi beni, particolarmente rilevante in un’epoca di crisi dei c.d. corpi intermedi ,partiti politici, istituzioni sociali e religiose, ecc., con la necessità di sistemi decisionali condivisi, ispirati non più alla sola rappresentanza, ma anche a forme di democrazia deliberativa e partecipativa.
Sicchè, a ben vedere la lettura offerta dalla Cassazione enfatizza il profilo dell’appartenenza, di utilità e di servizio. La prima riconosciuta alla collettività, la seconda all’ente esponenziale dotato di munus per salvaguardare la continuità funzionale del bene. Si è sostenuto, infatti, come lo schema proprietario si sciolga nella concretezza dei bisogni degli individui.
Se si condividono le suddette coordinate ermeneutiche ci si può spingere ad affermare la triplicità della appartenenza o la presenza di un concorso di diritti : allo Stato, perciò pubblico, ai cittadini uti singuli, al concessionario, il quale ne trae specifico utilità.
Ciò rileva ai fini della tutela approntabile; infatti, avrebbe poco senso riconoscere il concorso temporaneo di più diritti, ma l’azionabilità degli stessi solo a vantaggio di uno dei soggetti coinvolti.
L’interesse dei cives, dei cittadini, tutelabile giudizialmente, potrebbe essere individuato in ciò che, al termine della concessione e della interruzione della stessa, deve essere restituito alla fruizione comune, appunto, di ogni singolo cittadino.
Più in generale, l’art. 823, co. II, cc affronta il tema della tutela dei beni pubblici, affidandola all’autorità amministrativa, che può ricorrere alternativamente, agli strumenti civilistici di tutela del possesso e della proprietà, o alle tecniche di autotutela amministrativa.
In primo luogo, dunque, la tutela può concretizzarsi nelle azioni giudiziali petitorie e possessorie, in quanto, come precisato dalla Cassazione, la suddetta disciplina rappresenta un principio di carattere generale.
Qualora non intenda adire l’autorità giudiziaria ordinaria, o secondo alcuni unitamente a tale ricorso, la PA è legittimata a esercitare i poteri amministrativi di autotutela a difesa dei beni demaniali.
Potrà, quindi, annullare o revocare provvedimenti, a esempio concessori, precedentemente adottati in autotutela decisoria. Quanto all’autotutela esecutiva, è utile premettere che la Pa in genere esercita un’attività di cd polizia demaniale, finalizzata alla verifica dell’integrità del bene pubblico di uso generale e del suo utilizzo secondo le finalità istituzionali. I connessi provvedimenti sanzionatori spesso recano l’ordine di riduzione dei luoghi in pristino e sono dotati del carattere della esecutorietà, in quanto idonei a essere portati a esecuzione coattivamente anche contro la volontà del privato, e senza ricorrere all’autorità giudiziaria.
Come affermato dalla Cassazione, il potere in oggetto è espressione della supremazia della PA e può essere esercitato solo nei confronti di soggetti privati.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che oggetto di autotutela siano oltre i beni demaniali, anche i beni del patrimonio indisponibile, in virtù del loro particolare regime giuridico, assimilabile a quello dei predetti beni demaniali.
Saranno, invece, esclusi i beni del patrimonio disponibile, poiché la PA ne è titolare iure privatorum, e risulta carente di poteri autoritativi. Pertanto, soccorrerà il codice civile con le tecniche rimediali ivi disciplinate.
Ciò posto, giova dar conto dell’ambito di applicazione oggettivo dell’art. 823 cc, in quanto la giurisprudenza ne ha affermato la natura immediatamente precettiva, sul rilevo che la stessa rappresenti una clausola generale, la quale legittima la PA ad agire in autotutela, senza la necessità di specifiche norme. Tale esegesi trae spunto a contrario dall’art. 1032 cc, in tema di servitù negativa. Ad avviso delle Corti, il dettato della suddetta norma dimostra come il legislatore quando intende caratterizzare come programmatica una disposizione lo fa espressamente. Pertanto, ove ciò non è avvenuto, come nel caso dell’art. 823 cc, alla stessa norma è possibile attribuire una portata auto -applicativa.
Di contro, parte della dottrina ritiene che il contenuto della disposizione sia così generico da non poterle conferire efficacia auto- esecutiva. L’autotutela decisoria avrebbe, perciò, portata generale, mentre quella esecutiva andrà di volta in volta espressamente conferita. Del resto, l’art. 823, co. 2, si fa notare, non individua nemmeno l’autorità competente all’adozione di atti esecutori, rinviando, quindi, ad altra norma attributiva del potere.
La giurisprudenza, inoltre, si è pronunciata in merito alla relazione cronologica fra azione giuspubblicistica, l’autotutela, e le azioni privatistiche, possessorie e petitorie.
È stato affermato il principio del parallelismo, in forza del quale il termine di decadenza annuale, previsto dall’art. 1168 cc per l’azione di spoglio si estende per analogia anche alla tutela del possesso posta in essere in forma autoritativa. Dunque, la PA, per potersi riappropriare del bene, dovrà percorrere il tortuoso sentiero dell’azione di reintegrazione, imprescrittibile, e, perciò, priva di preclusioni temporali.
Tuttavia, secondo alcuni autori non ricorrerebbero i presupposti giustificativi dell’analogia iuris, e dunque, un vuoto normativo. Infatti, si è osservato che nel diritto amministrativo in genere vige il principio in base al quale il potere amministrativo non è sottoposto a termine, salvi i casi previsti dalla legge.
Inoltre, sarebbe arbitrario applicare a una categoria di azioni i termini dell’altra.
La giurisprudenza si è a lungo interrogata sui rapporti fra l’azione civile di accertamento della proprietà e l’autotutela amministrativa.
È opinione diffusa che la pendenza di una rei vindicatio precluda alla PA l’azionabilità dei poteri di autotutela; ciò al fine di evitare che la stessa, con il proprio intervento, possa incidere su situazioni giuridiche la cui titolarità è contestata e pendente presso l’autorità giudiziaria, con l’inevitabile conseguenza di sostituirsi di fatto a quest’ultima.
Infatti, l’autotutela assolve sia le funzioni ripristinatorie che quelle rivendicatorie; esercitarla in pendenza di un giudizio civile equivarrebbe a sostituirsi surrettiziamente al GO.
Qualora lo faccia, la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario, trattandosi di atto affetto da carenza di potere in astratto. Sarebbe, quindi, più opportuno attivare l’azione civile non prima dell’esercizio dell’autotutela, così che il relativo provvedimento sia pienamente legittimo.